AFFINITA' ELETTIVE
UNA LETTERATA
D'AVANGUARDIA: LUISA BERGALLI

Nel 1725 al teatro di San Moisè andava in scena un melodramma, l’Agide, composto per la prima volta da una donna: Luisa Bergalli. Nonostante la nascita umile, avvenuta il 15 aprile del 1703 a Venezia, riuscì a darsi una solida formazione culturale, dovuta alla protezione e all’amicizia soprattutto di Apostolo Zeno e all’apprendistato pittorico alla scuola di Rosalba Carriera. Quindi si avviò ad una carriera letteraria e visse, dato eccezionale per l’epoca, dei proventi della sua attività intellettuale. Accademica arcadica con nome di Irminda Partenide, scrisse tragedie e commedie per il teatro, per il quale operò anche nel ruolo di capocomica e lavorò alla valorizzazione dell’apporto femminile alla letteratura, pubblicando nel 1726 la fondamentale raccolta dei Componimenti poetici delle più illustri rimatrici di ogni secolo. Curò anche un’edizione delle Rime di Gaspara Stampa. Con il matrimonio con lo scrittore e giornalista Gasparo Gozzi iniziava un sodalizio intellettuale che la portò a condividere i numerosi progetti editoriali del marito, dalle traduzioni alle rime per nozze, a cui iniziarono in seguito sa collaborare anche i numerosi figli, pressati dalle difficoltà economiche. Coordinò una raccolta di rime in onore di Caterina Dolfin Tron, divenuta nel 1773 procuratessa di San Marco a fianco del potente marito, cui parteciparono molte letterate, tra le quali anche Eleonora de Fonseca Pimentel.
Canzone 2
Chi avesse nel capo la pazzia
Chi
avesse nel capo la pazzia,
E dentro al petto il gaudio suo fratello,
Veggendo questo Gatto in un avello,
Bisognerebbe discacciargli via.
Non era mica di quella genia,
Che graffia, morde e ruba a questo, e a quello;
Egli erra un Gatto sì pulito, e bello,
Che un topo gli avria usata cortesia.
Certo che gli piacea far all' amore;
Ma dicono gli Autor, che questo fanno
Le persone gentili, e di buon core.
Pur non tesseva a le Donzelle inganno;
Voleva dichiararsi servitore
D' una, che fu cagion del suo malanno;
Quei tetti, ohimè! lo sanno,
Che veggendol cader da l' alto al basso,
Rimaser freddi, fermi come un sasso.
Balestrieri, Domenico, Lagrime in morte di un gatto (Milano: G. Marelli, 1741), p. 23.
Storia di Venezia città delle donne-Guida ai tempi, luoghi e pre-senze femminili-testo storico di Tiziana Plebani.
CRISTINA DA PIZZANO
la poetessa delle vedove…

Cristina da Pizzano in una miniatura
A
quattro anni Cristina da Pizzano lascia Bologna la Grassa, per seguire la sua
famiglia in Francia, a Parigi, su richiesta del Re Carlo V che vuole il padre,
Tommaso, accanto a sé come medico, consigliere e astrologo. E infatti
alla morte del Re nel 1380, Tommaso è presente insieme ad un altro “fisico”
(medico) del re. Tommaso ha affermato, in verità, che il Re era fuori
pericolo e teme che la sua errata previsione e la conseguente morte del sovrano
lo privino del favore di cui prima godeva.
Tommaso ha studiato a Bologna, sede di una famosa Università, poi è
stato chiamato al servizio della Repubblica di Venezia e si è sposato
lì con la figlia di un dottore in medicina. Una figlia di nome Cristina
(ma seguirono anche due maschi, Paolo e Aghinolfo) nasce da questo matrimonio
ed è a lei che dobbiamo tutto quanto si sa della sua famiglia e del Re
che la protegge. Cristina, ragazza affascinante e assai corteggiata, è
sposata all’epoca della morte del Re con Etienne Castel, figlio di un
ciambellano del re, che esercita saltuariamente anche la carica di ufficiale
addetto alla conservazione delle armi, e già si annuncia la nascita di
un erede.
Grazie al favore del re, Cristina e la sua famiglia vivono agiatamente. Cristina
ha avuto un’infanzia felice, colma di tenerezza, che le ha permesso di
fiorire e di acquistare coraggio. A Cristina non piace filare, ha sete di sapere.
Alla morte di Carlo V scoppiano tumulti tra gli studenti e le guardie reali
e il suo successore, il suo primogenito Carlo, non ha che dodici anni. Nessuno
nella cerchia del nuovo re si cura di prolungare il favore di cui fino ad allora
ha goduto e la famiglia si sente scivolare nelle ristrettezze. Tommaso muore
in una data imprecisata ma che egli stesso sa pronosticare esattamente.
In seguito, lo sposo di Cristina prende congedo da lei per accompagnare il re
che si trasferisce a Beauvais e muore, a soli trentaquattro anni, vittima forse
della peste:
Sono
vedova, sola e di nero vestita
col viso triste semplicemente acconciata;
con grande corruccio abbandonata al dolore
porto l’amarissimo lutto che mi uccide.
Rimasta vedova a venticinque anni con tre figli, Cristina è abbattuta dal dolore desiderando più morire che vivere. In questo quadro di sofferenza profonda si aggiunge una moltitudine di miserabili occupazioni. Cristina per i suoi deve assumere la guida della famiglia. Gli stipendi dei notai reali non sempre all’epoca sono pagati con regolarità; passeranno più di ventuno anni prima che Cristina possa recuperare gli arretrati dovuti a suo marito dalla Corte dei Conti. Deve intentare un processo che durerà tredici anni e che vince ma deve aspettare per avere la somma dovuta. Il debito saldato è considerato come una gratificazione e non come il pagamento di una somma dovuta a Etienne Castel. Ciò è sentito come un’ingiustizia da Cristina che l’improvvisa scomparsa del marito lascia totalmente inerme, obbligata giorno dopo giorno a battersi da sola contro creditori senza scrupoli. Investe una piccola somma di danaro lasciatale dal suo sposo affidandola ad un mercante che le fa credere che è stato derubato. Altro processo (ne ha per quindici anni) che è perso perché le prove di tale circostanza sono difficili da provare. Iniziano altri processi con grandi spese e costi. Cristina cade malata e, pur nella malattia, deve decidersi, alla fine del 1392, a vendere l’eredità lasciatale dal padre, per tamponare i debiti più pressanti ed imparare tra l’altro che si può essere diffamata senza motivo. La sua arma segreta dinanzi a tante avversità? La poesia che ama da sempre. Proprio nell’anno della morte del marito – il 1390 – prende parte a un concorso poetico e la sua ballata è ben accolta. Spesso proietta il suo scoraggiamento nei versi, come in questa ballata (nel 1399 ne ha scritte cento):
Ahimé
dove dunque troveranno conforto
povere vedove dei loro beni spogliate
giacché in Francia che seppe essere il porto
della loro salvezza, e dove le esiliate
potevano rifugiarsi, e anche le smarrite,
oggi non trovano più amicizia.
I nobili non ne hanno alcuna pietà
Né di più ne hanno i chierici, grandi o meno importanti
(…)
Si cimenta in tutti i generi della poesia cortese allora in uso, oltre alla
ballata già citata, i lais o virelais, i rondeaux, i jeux à
vendre e anche tutti i temi in voga: Cristina è ora l’amante ora
la Dama e tocca tutti i temi che Amore può suscitare, come il mal di
lontananza o quello della speranza o dell’attesa e della rottura.
I suoi versi più belli, appassionati e avvincenti sono quelli che cantano
il lutto, il dolore, lo sconforto e anche quella necessità in cui ella
si trova di recitare in poesia una commedia perpetua. Ma un tema in particolare
le sarà caro, quello delle vedove abbandonate che sviluppa attraverso
il mito di Semiramide in La Cité des femmes. Semiramide è
per Cristina la donna sola, autonoma, coraggiosa, insomma la vedova. Inoltre,
grazie alla sua lunga esperienza, Cristina dispensa consigli alle vedove e scrive
una sorta di trattato sull’educazione della donna, il Livre des trois
vertus. La sua carriera è sorprendente: in sei anni scrive quindici
volumi che si cura anche di far ornare di deliziose miniature. Il successo subito
risponde al suo sforzo.
Verso la fine del secolo gli avversari di una volta, re di Francia e re d’Inghilterra,
moltiplicano i gesti di distensione. Cristina riceve una proposta da John Montagu,
conte di Salisbury: inviare suo figlio maggiore, Jean Castel, in Inghilterra
poiché anche lui ha un figlio, Thomas, anche lui di dodici o tredici
anni, con il quale Jean può essere allevato e ricevere un’educazione
da cavaliere: è la sua opera, la sua poesia che l’hanno fatta notare
dal grande signore inglese. Ma Salisbury è fatto prigioniero, il re deposto,
messo in prigione e è eletto nuovo re il duca di Lancaster. Salisbury
e alcuni altri tentano un colpo di mano che fallisce in seguito ad un tradimento.
Il re d’Inghilterra, Riccardo II e Salisbury sono assassinati. Cristina
perde il suo secondo figlio, sua figlia manifesta il desiderio di prendere il
velo e Jean sta per rientrare ma non tornerà mai più in Inghilterra.
Cristina cerca allora il favore del Duca di Milano, Gian Galeazzo Visconti che
però è assassinato. Alla fine Jean rimane in Francia e ottiene
come suo padre la carica di notaio e segretario del re. Cristina canta nei suoi
versi le lotte tra la Francia e l’Inghilterra.
Ma ecco all’orizzonte un altro impegno per la nostra indomita poetessa:
una polemica letteraria che diventa la prima disputa antifemminista della storia.
Cristina non ama il famosissimo Roman de la Rose, best-seller dell’epoca,
vera e propria Bibbia per gli universitari, composto di due parti: la prima,
del 1245, scritta da Guillaume de Lorris, è l’opera cortese per
eccellenza, allegorica e un po’ preziosa; la seconda, è scritta
cinquant’anni dopo da un universitario di Parigi, Jean de Meung, che decide
di completare l’opera incompiuta di de Lorris. Questa seconda parte accentua
la visione del professore che disserta, dell’universitario che si sente
superiore agli altri anche in virtù dei suoi diplomi. Presto Cristina
attacca Honoré Bouvet che è nominato membro di una commissione
che deve controllare le evasioni fiscali e si avvale della protezione di Jean
de Meung. Cristina rimprovera ai nobili, ai grandi di quel mondo che non ha
smesso di frequentare, di mancare ai propri doveri e questo è dovuto
alla perdita dei valori cortesi che coincide con la scomparsa del ruolo delle
donne. Attacca la seconda parte del Roman de la Rose, biasima Jean
de Meung, l’anticortese per eccellenza, il misogino, che ha compilato
un processo contro le donne e ha insegnato ai potenziali seduttori i mezzi per
vincere una pulzella con frode e astuzia.
Jean de Montreuil, preposto di Lille e segretario del re redige nel 1401 un
trattatelo in francese, oggi perduto, che invia ad notabile chierico
– probabilmente il maestro Gontier Col legato alla cancelleria reale.
Jean de Montreuil, dopo aver letto il Roman de la Rose, loda il suo autore,
ma Cristina impugna la penna. Col risponde, c’è uno scambio epistolare.
Ma Cristina trova un appoggio, Jean Gerson che mette pubblicamente in discussione
le parole di de Meung. Cristina - garante dell’Ordine della Rosa - vuole
portare il dibattito che agita i signori della Sorbona davanti alla regina stessa
che apprezza il suo talento. L’ultima parola di questo dibattito spetta
a Cristina, conscia del mutamento che avviene nella sua epoca.
Ora Cristina ha una grande occasione, una promozione: Filippo l’Ardito
la incarica di scrivere il resoconto del regno di Carlo V suo fratello ma quando
ha appena terminato la prima parte dell’opera apprende che il duca è
morto. Continua a scrivere e due anni più tardi il duca Giovanni acquisterà
il suo manoscritto. Scrive alla regina Isabella di Baviera, avvertendo i pericoli
di uno scontro fra Luigi d’Orléans e Giovanni Senzapaura, tra Francia
e Borgogna, chiedendole di assumere il ruolo di arbitro. Luigi è ucciso
in un agguato, Giovanni Senza paura confessa il suo crimine.
Cristina è stata letta anche oltre le frontiere con maggiore attenzione
che in Francia, ma qui c’è qualcuno la cui voce sarà molto
ascoltata a partire dal 1408: Jean Petit. Si tratta di un dottore dell’Università
di Parigi intervenuto nel dibattito sullo scisma del papato. Diviene in seguito
consigliere e portavoce ufficiale del Duca di Borgogna che ben aveva agito a
far uccidere il duca d’Orléans, colpevole di lesa maestà,
tradimento, stregoneria e il re aveva il dovere di ricompensarlo. Questa è
l’arringa che fa Jean Petit a Parigi. I contemporanei sono coscienti del
potere sia morale che politico che essa detiene e l’omicida era riuscito
a ribaltare l’opinione in suo favore. Cristina cerca di operare sempre
la pace. Pensando alla lotta tra borgognoni e armagnacchi, alle scene di violenza
a cui aveva assistito, all’orrore di questa guerra condotta senza curarsi
di ogni sentimento umano, di ogni legame fraterno tra gente che viveva nella
stessa terra e parlava la stessa lingua, inizia a comporre una nuova opera:
il Livre des faits d’armes et de chevalerie. Quest’opera
dimostra quanto Cristina si sia interessata profondamente di tutte le preoccupazioni
del tempo, anche di quelle più lontane dall’ambito femminile. Cristina
inizia altre due nuove opere, il Livre de la paix che dedica al delfino
Luigi di Guienna dove moltiplicherà i suoi consigli al principe perché
si faccia amare dai suoi sudditi e si circondi di cavalieri forti e giusti e
lo esorta alla clemenza, alla verità e alla generosità e le
Heures de contemplation sur la passion de Notre-Seigneur nelle quali tenta
di consolare le donne rattristate dal lutto per la morte del duca di Borgogna.
Cristina, che si è sforzata di riportare in tempo utile un po’
di saggezza in un mondo in preda alla follia, passerà gli ultimi anni
in convento a Poissy (anticamera del cimitero) vicino a sua figlia. Anche la
poesia, che era stata la sua estrema risorsa, le sembrava in quel momento futile,
superata, spropositata alla durezza dei tempi. Ma, in seguito all’assedio
tolto a Orléans da parte di Giovanna la Pulzella e all’incoronazione
di re Carlo a Reims, Cristina, dopo undici anni di silenzio, riprende la penna:
scrive cinquantasei strofe piene di entusiasmo e emozione:
Ecco
una donna, semplice pastorella,
più prode di quanto mai uomo fu a Roma.
Giovanna, che risponde pienamente ai desideri di Cristina, è la donna sola per eccellenza, unica, risoluta e a Cristina non sembra vero, a lei che ha passato una parte della sua esistenza a tentare di convincere i contemporanei che sbagliavano a disprezzare la donna:
Ah!
Quale onore al femminile
sesso che Dio ama…
Giovanna avrà gli stessi nemici di Cristina, gli universitari di Parigi. Non si conosce con precisione la data della morte di Cristina
LOUISE LABÉ:
“La Belle Cordière”, la più grande poetessa femminista
del Rinascimento francese,
avventuriera e donna di mondo
Louise,
figlia di un ricco cordaio soprannominato Labé (il vero cognome era Charlin,
o Charly), nacque a Lione nel 1524; sposò un altro cordaio di lei molto
più anziano.Vedova ancora giovane, si ritirò vicino a Lione. Di
prospera e mercantile borghesia, simile a quella che illustrava le città
italiane dell’epoca, ricevè raffinatissima educazione, conosce
il latino e l’italiano, appassionata di scherma e d’equitazione,
secondo una leggenda, travestita da uomo segue un amante all’assedio di
Perpi-gnan (1542): talché il titolo che le rimase di “Belle Cordière”,
segnava meno la sua appartenenza sociale, e più il risalto che ne derivava
alla sua diversa personalità. Dei suoi amori, si conosce quello più
celebre ma non unico oggetto delle amorose poesie, del poeta Olivier de Magny,
al quale dedica i sonetti. Con Olivier de Magny, nella sua casa lionese, si
riunivano Clément Marot.Maurice Scève, Pontus de Tyard, Pernette
du Guillet.
Morì presto a 44 anni nel 1565 in una solitudine che durò anni
senza nemmeno ritentare il conforto di scrivere, benefattrice dei poveri.
L’opera: un’operetta dialogata in prosa, Débat de Folie et
d’Amour; Poèmes che hanno tutto da guadagnare avvicinandole, come
quasi fu fatto a loro modello, alle Rime, della più o meno contemporanea,
Gaspara Stampa (edite 1554); Elégies (tre), Sonnets (24 - uno dei primi
autori francesi a che utilizzano la forma del sonetto). Rara qualità
formale.
“Femminismo” e Rinascimento
Nell’Epistola in cui dedica le sue opere all’amica Clémence
de Bourges, Louise afferma il ruolo fondamentale della donna per il Rinascimento:
ciò che conta per le donne di quei nuovi tempi non sono più i
vestiti, le collane, gli anelli, ma piuttosto una presa di coscienza di sé.
La donna deve essere se stessa e non definirsi attraverso lo sguardo che gli
altri portano su di lei.
“L’architettura” del canzoniere (24 sonetti):
1) Omaggio a Petrarca
2) “innamoramento”
3) turbamenti della passione
4) relazione fra musica e poesia
5) fantasmi della relazione amorosa con l’amato e desiderio di una vita
solitaria
6) giustificazione presso il lettore dei suoi smarrimenti amorosi e desiderio
di simpatia.
NOËLLE CHÂTELET
Un po' di vita... Noëlle Châtelet IN 8 DATE:

16
ottobre 1954: nascita a Meudon.
1979:
introduzione e note a Justine ou les Malheurs de la vertu di Sade.
1980: attrice ne La Banquière, film di François Giroud
1987: Histoires de bouches, (Mercure de France) Goncourt del racconto.
1989-1992: direttrice dell’Istituto di francese di Firenze.
1995: costituzione del comitato di sostegno a suo fratello Lionel Jospin, candidato
alla presidenza della
Repubblica.
1996: La Dame en bleu (Stock), romanzo.
1997: La Femme coquelicot (Stock), romanzo.
Il libro che preferisco: La courte échelle

Mi
colpì immediatamente per la scelta dell’argomento e per come lo affronta.
Parlo del romanzo La courte échelle. E’ un’espressione francese che indica
l’atto di porgere le mani e le spalle a qualcuno per
aiutarlo a salire.
Un vecchio mulino in riva al fiume, da qualche parte in Francia. E’ là
che un uomo di una sessantina d’anni trascina una donna più giovane,
che conosce appena, prostrata da un immenso dolore. Per alcuni giorni, Pierre
cercherà pazientemente, con ostinazione, di dare a Jeanne il gusto di
rivivere. Come un giusto ritorno delle cose, imparerà da lei ad accettare
la sorda minaccia che aleggia su di lui.
Silenzi e rumori sembrano scandire questa storia sconvolgente, silenzi della
luna, sciabordii dell’acqua, mutismo di Jeanne, maldestre allegrie di Pierre.
Per averne un’idea:
Quest’uomo che non le è nulla, perché, verso
cosa la forza? Con quale diritto le ordina di alzarsi, di riprendersi, di riempire
una valigia per l’estate degli altri, di lasciare i suoi punti di riferimento,
il tappeto della camera, i riflessi domestici della fuliggine sulle cose?
”Due settimane, due brevi settimane”, ha concesso. Già quelle due lunghe
settimane le sembrano interminabili (p. 19).
In effetti, quando un dolore ci colpisce togliendoci ogni energia, ogni capacità
di reazione, non ci piacerebbe che qualcuno ci prendesse quasi di peso, quasi
contro la nostra stessa volontà per farci scoprire che amiamo ancora
la vita? Abbandonarsi in mani amorevoli che si occupano di noi, quando noi non
siamo in grado di farlo, propri come quando eravamo bambini…
Gli altri… La femme coquelicot

Marta
ha settant’anni. Si potrebbe credere che non sia più l’età della
passione. Tuttavia è proprio una passione che vivrà con Félix,
un vecchio artista di ottant’anni, quello che lei chiama “l’uomo dalle mille
sciarpe da collo”. Ed ecco che Marta si risveglia ai colori della vita, al rosso
del desiderio. Figli e nipoti assistono con stupore alla sua metamorfosi di
ragazza romantica che assapora, infine, il piacere di amare e di essere amata.
Grazie a questo romanzo leggero come un racconto, un velo pudico si alza sulle
passioni tardive.
Per averne un’idea:
Una ragazzina. E’ proprio da ragazzina che esplora contemporaneamente
le mille ed una sfaccettatura dell’uomo dalle mille sciarpe da collo. E’ imprevedibile
come i suoi fazzoletti, la stupisce. E’ ciò che dice, ciò che
fa, insomma: ciò che è la stupisce. La sua presenza, in sé,
è un avvenimento. L’uomo dalle mille sciarpe da collo compone uno spettacolo
in cui la sorpresa è assicurata. L’inatteso inteso (p. 59).
La dame en bleu

Per
Solange, bella, passata la cinquantina, un lavoro, un amante, tutto un giorno
crollerà, per strada, con l’incontro di una vecchia signora in vestito
di crespo blu che va secondo il suo passo, tranquilla in mezzo alla folla febbrile.
Questo passo, questa nuova cadenza, Solange li sceglie a sua volta come un privilegio.
Diventare una vecchia signora in blu è ormai la sua occupazione essenziale
e voluttuosa. Scopre la delizia delle armi deposte, la grazia di fuggire alle
esigenze illusorie.
Per averne un’idea:
Solange si china verso lo specchio. Il capello bianco,
vicino all’orecchio, sta spuntando. Occorre dire che lei lo coccola. Gli parla,
gli fa le moine, proprio come alle piante del salotto, sforzandosi di mantenerle
in vita in quella stanza della casa definitivamente abbandonata.
Anche se altri capelli bianchi l’ hanno raggiunto, non solo sulle tempie ma
anche nel corvino della capigliatura priva ormai dei ritocchi di tintura, è
tuttavia quel capello che è per lei oggetto di una particolare tenerezza.
D’altronde di tenerezza lei ne ha da vendere. Ne ha per tutti i
segni di abbandono del viso e del corpo: queste minime sgualciture della pelle
che scopre la mattina, li accarezza con la punta delle dita, le incoraggia con
lo sguardo (…)(p. 53).
Hanno scritto di lei:
Libération
Lunedì 2 ottobre 1997
Noëlle Châtelet, 53 anni, è universitaria e scrittrice.
E’ anche la sorella di Lionel Jospin. Completamente
indipendente
L’anima
gemella
Sorella di. Moglie di. Figlia di. Esistere senza di loro. Al di
fuori di loro. Prima e dopo di loro. Né a fianco, né un passo
indietro, né nell’ombra. Esistere come loro. Noëlle Châtelet
è la sorella di Lionel Jospin. Primo ministro. E’ anche la vedova di
François Châtelet, filosofo. Ma è, prima di tutto, scrittrice,
universitaria, moralista. Lavora sulla pesantezza dei corpi, la tirannia delle
apparenze o il piacere di invecchiare. Fa parte di giurie letterarie, presiede
la Casa degli scrittori, anima laboratori di scrittura. Ha la propria notorietà
solitaria e la propria aurea nel mondo intellettuale. Prima, è stata
attrice con Marguerite Duras, amica lesbica di Romy Schneider nel film La Banchiera
o prefattrice di Justine ou les Malheurs de la vertu, opera dell’incantevole
marchese de Sade.
“Per ventuno anni sono stata la moglie di Châtelet. Ora sono la sorella
di Jospin”. Lo dice senza aggressività, senza cedere nulla delle sue
tenerezze, ma interrogandosi onestamente sull’ambiguità dell’interesse
mostrato per la sua opera. François aveva diciannove anni più
di lei ed era uno dei suoi professori. Lionel ha sette anni più di lei
ed è il primogenito dei fratelli. Nonostante l’importanza dei suoi mandati
nella repubblica delle lettere, nonostante l’autorevolezza dei suoi pareri sulla
bellezza standardizzata o il tabù della sessualità dei vecchi,
Noëlle, 53 anni, conserva ansietà di ragazza sposata troppo presto,
ammirazioni di ultima nata esaltata dalla riuscita dei grandi (…).
Luc Le Vaillant
Traduzioni
dal francese di Fausta Genziana Le Piane
![]()
.
ALBERTINE
SARRAZIN...
Una vita incredibile ed una scrittura insolita
Come dimenticarla? La sua immagine è incancellabile in me dal momento in cui ho scoperto L’astragale e la sua vita.

Nata
ad Algeri nel 1937, Alberatine è una ragazza fuori del comune, esempio
di rabbia di vivere e di libertà per generazioni. Abbandonata in orfanotrofio,
vi riceve il nome di Albertine Damien. La bimba ha almeno due nutrici prima
di essere adottata, a due anni, da una coppia di una certa età (lui medico
colonnello). La famiglia lascia Algeri per istallarsi ad Aix-en-Provence.
L’infanzia di Albertine è segnata da sofferenza e umiliazioni: uno stupro
a 10 anni da un membro della famiglia adottiva, un conflitto permanente con
i genitori. Il suo carattere si afferma per reazione e si scaglierà in
seguito con forza contro le convenzioni e questa società che l’ha sfavorita.
Albertine si rivela tuttavia molto dotata per le lettere. Le sue materie preferite
sono quelle artistiche e soprattutto la letteratura. Fin dall’età di
14 anni ha un diario che continuerà in pratica fino alla morte e che
sarà poi pubblicato.
Ma il suo carattere indomabile e le difficili relazioni con i genitori adottivi
la portano al Bon Pasteur di Marsiglia da cui evade il giorno del suo esame
orale di maturità per rientrare a Parigi in autostop. Comincia allora
per lei una vita clandestina poco raccomandabile. Poiché, anche se approfitta
per soddisfare i suoi gusti artistici visitando i musei e leggendo moltissimo,
fa la dolorosa esperienza della prostituzione. Nel 1953, un mancato furto la
manda in prigione a Fresnes poi a Doullens dove è trasferita nel 1956.
E’ evadendo da questa prigione, il 19 aprile 1957, saltando da un muro di 10
metri, che Albertine si rompe l’astragalo.


Dal
romanzo L’astragalo è stato tratto il film “L’Astragale” (1968).
Regia: Guy Casaril
Interpreti: Marlène Jobert (nella parte di Anne) - Horst Bucholz (nella parte
di Julien) - Magali Noël - Claude Génia - Georges Géret
trailer
Per
averne un’idea… Ecco come lei stessa, all’inizio del romanzo, descrive la caduta:
Uno
Il cielo si era allontanato di dieci metri almeno.
Restai seduta, non avevo fretta. Il colpo doveva aver spezzato le pietre, con
la destra tastavo schegge. Man mano che respiravo, il silenzio attenuava l’esplosione
di stelle i cui frammenti cadevano ancora crepitando nella mia testa. Il profilo
bianco delle pietre rischiarava debolmente l’oscurità: la mia mano si
staccò da terra, passò sul braccio sinistro, risalì fino
alla spalla, discese lungo le costole fino al bacino: niente. Ero intatta, potevo
continuare.
Mi misi in piedi. Con il naso bruscamente proiettato contro i rovi, stramazzata
a croce, mi resi conto di non aver verificato le gambe. Forando la notte, voci
sagge e note salmodiavano: “Attenzione, Anne, finirai per romperti una zampa!”.
Mi rimisi a sedere e ripresi l’esplorazione. Questa volta trovai, all’altezza
della caviglia, un’escrescenza strana che si gonfiava e pulsava sotto le dita…
Alberatine Sarrazin, L’astragalo, l’ancora del Mediterraneo, 2001, p.7
Un
uomo passa, la raccoglie e la cura: è Julien Sarrazin, che due anni dopo
diventerà suo marito. Per loro inizia allora un lungo periodo di avventure
diverse e di furti. Passano da arresti in evasioni, incrociandosi ma non ritrovandosi
quasi mai. Se i loro corpi e la loro salute s’indeboliscono (grave incidente
di macchina nel 1961 seguito da un’operazione nel 1963 per Albertine) il loro
amore, al contrario cresce sempre di più. Sarà, d’altronde, all’origine
di una corrispondenza che avrà degnamente posto nella letteratura epistolare
amorosa.
Durante il soggiorno in prigione, Albertine redige i suoi due primi romanzi:
La Cavale e L’Astragale.
Nel 1964 infine, Albertine e Julien, liberi, si ritrovano e si sistemano in
una vecchia casa delle Cevenne. Albertine viene a sapere che le sue opere saranno
pubblicate dall’editore Jacques Pauvert. Il successo è immediato.
Adulata da quelli stessi che l’hanno disprezzata, è tradotta in tutte
le lingue. E’ sollecitata, fotografata, le chiedono autografi. E’ la rivincita
sulle sofferenze passate.
La sua singolare bellezza, la sua spiritualità, la sua fantasia sono
apprezzate e lei moltiplica le interviste. Albertine è rapita da questa
nuova gloria di cui non dubitava e che aspettava con impazienza ; anche se non
è una stupida e sa riconoscere dove si trova l’ipocrisia, sa che alcuni
non sono mossi dall’ammirazione per la sua opera ma da una curiosità
malsana. Ma chi è dunque questa giovane donna dal passato tumultuoso,
che ha passato la maggior parte della sua esistenza in prigione?
Nel 1965, Albertine e Julien s’istallano a Montpellier. Comprano l’Oratoire,
una vecchia fattoria (mas) situata alle Matelles, vicinissimo a Montpellier.
Vi s’istallano nel 1967.
Intanto Albertine pubblica il suo terzo romanzo, La Traversière, opera
scritta in libertà contrariamente alle altre due. Là ancora, un
successo. Ma non ha il tempo di approfittarne; la sfortuna non l’ha abbandonata
del tutto e deve subire parecchie operazioni all’astragalo. E di complicazioni
in errori e incurie mediche, Albertine, al culmine della gloria, soccombe sul
tavolo operatorio di una clinica di Montpellier il 10 luglio 1967. Julien intenterà
contro i medici un processo che vincerà.
Albertine era piena di rabbia di vivere. Aveva molti progetti, in particolare
l’adattamento al cinema de L’Astragale. Il suo desiderio è stato realizzato,
ma non ha avuto il tempo di gioirne. Non ha mai saputo che i suoi romanzi sono
naturalmente entrati nella letteratura classica, che sono studiati in Facoltà,
che sono oggetto di argomento agli esami di letteratura, che le sue poesie sono
state musicate. Non ha mai saputo quante tesi sono state prodotte in Francia
e all’estero su di lei, quante testimonianze si trovano in suo ricordo: Julien
ha fondato una casa editrice per pubblicare gli inediti della moglie. Montpellier
ha la propria Casa per tutti Albertine Sarrazin. Les Matelles ha dato alla sua
casa di campagna il nome di Albertine Sarrazin. E Valflaunès, piccolo
paese vicino alle Matelles, con l’organizzazione di un concorso di novelle,
il Premio Albertine Sarrazin, partecipa ogni anno a perpetuare il ricordo dell’autrice.
Poèmes/Poesie
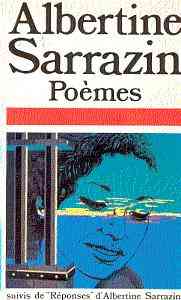
La maggior parte delle poesie è stata scritta in prigione.E’ impossibile tradurre la poesia seguente poiché se ne tradirebbe la grande musicalità.
Ballade des suicidés
Que
faut-il? Souvenir
Dans la nuit qui persiste
Et si doucement triste
Qu’on voudrait en mourir ?
-Ô en mourir
sans souffrir
mort altière
Vers la rivière !
- Rien que reflets dans l’eau
Sous les murs murnurante
La lune crie, mordante :
« Monte là, c’est plus beau ! ».
-
Je viens à toi,
Lune ! Dis-moi,
Ô l’éternelle
Pourquoi, si belle ?
-
Recherchez-vous encor
Cette ardente gelure ?
Et votre chevelure
Plaît-elle au gouffres morts ?
O
les noyés
Asphyxiés !
Ô mes pendus !
Ô mes voix tues.
21-9-1952
Réponses/Risposte
Réponses
raggruppa estratti di interviste che Albertine ha concesso prima della sua definitiva
liberazione. Parla di argomenti che le stanno a cuore e di se stessa : la gioventù,
la prigione, la libertà, la società, l’ambiente e la prostituzione,
la libertà sessuale, variazioni su un viso. Questi testi, che rispettano
lo stile parlato e la spontaneità, mostrano quanto la sua vita e la sua
opera siano strettamente legati.
Variations sur un visage/Variazioni su un viso
“Il viso è un punto interrogativo, un enigma. Credo che si possa sempre
modificarlo, almeno gli si può dare un’espressione.”
Albertine Sarrazin, L’Astragale
Mi
controllo tantissimo, per esempio sono estremamente miope. Per anni sono rimasta
senza voler portare occhiali. Stavo sempre attenta a guardare la gente dritto
negli occhi, e non la vedevo. Occhi spalancati, non batter ciglio, per non mostrare
che ero miope, e veramente non si vedeva. Ci sono un mucchio di trucchi come
questo, come il mio zoppicare, ogni passo che faccio ci penso, cerco di non
trascinare troppo la gamba mentre fisiologicamente dovrei zoppicare molto basso.
Gli occhi, perché mi sono abituata a farli per reazione, perché
in prigione è formalmente vietato, e ogni trucco è evidentemente
confiscato, allora bisogna inventare e ogni mattina rischiare di farsi pulire
con la glicerina dalle sorveglianti (…).